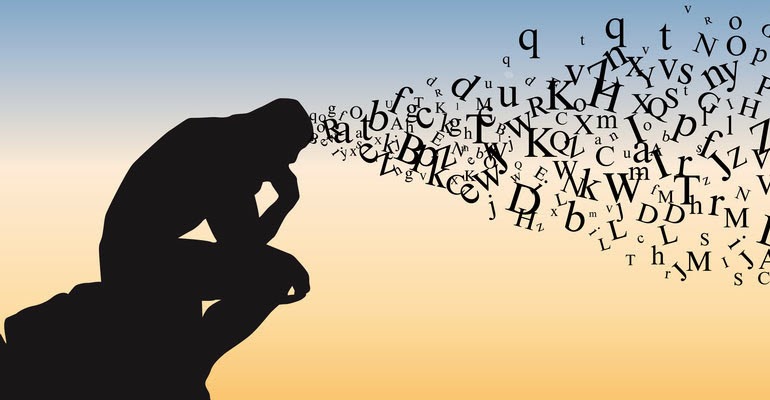
Cosa vorrà mai dire “un periodo così”? Certamente neppure Holden lo sa, forse lo immagina ma certamente non lo sa nei termini in cui si può sapere quel che si è detto dopo averlo messo alla prova di un trattamento discorsivo. Certo non è il vecchio Spencer ad aiutarlo in tal senso, col suo modesto “Non lo so, figliolo. Non lo so”. Anche in questo caso la “rabbia” di Holden è il sentimento che accompagna la sua presa d’atto che neppure questa è una risposta, così come neppure quelle precedenti erano state domande. Quel “dico bene?” rimane nell’aria, nell’attesa vana di un conferimento di senso che non arriva. Preso atto dell’impossibilità di comunicare, è forse alla fortuna che il giovane Holden si deve affidare?
Nel 1951 veniva pubblicato negli Stati Uniti un libro destinato ad un immediato e duraturo successo, The Catcher in the Rye, di J. D. Salinger, tradotto in Italia dieci anni dopo col titolo Il giovane Holden (Salinger 1961). Quale rapporto, ci domanderemo qui, il personaggio del romanzo, Holden Caulfield, stabilisce col linguaggio? Le interazioni discorsive che nell’arco di soli tre giorni Holden stabilisce con una varietà di altri personaggi, in quale rapporto stanno con i suoi frequenti attacchi di “voltastomaco”? A che cosa precisamente si ribella un personaggio che, come Holden, è diffusamente e sbrigativamente noto come un “ribelle”?
Holden Caulfield è un sedicenne newyorkese che, avendo “fatto fiasco” in quattro materie su cinque, alla fine del primo trimestre viene “sbattuto fuori” dalla scuola in cui studia, “Istituto Pencey”: un istituto che sugli annunci pubblicitari presenta se stesso in un modo che fin dalla seconda pagina della sua “storia” Holden giudica “buono per i merli”: “Dal 1888 noi forgiamo una splendida gioventù dalle idee chiare”. Va da sé che Holden non si considera un merlo – ma semmai, e a seconda delle circostanze, “un fenomenale bugiardo” o “un dannato vigliacco” o “un pazzo”… – e le ragioni del suo essere qualcos’altro compaiono un po’ per volta nel corso del suo racconto. A partire dalla visita di commiato resa al suo professore di storia, il professor Spencer.
Il “vecchio Spencer” vive con la moglie – “tutt’e due sulla settantina, e forse anche più” – poco distante dalla scuola, ed è in camera sua, seduto in poltrona e con l’influenza, quando Holden lo va a salutare:
Quando bussai mi guardò – Chi è? – gridò. – Caulfield? Vieni, figliolo – Gridava sempre, quando non era in classe. Certe volte dava sui nervi. (…) Come va la sua influenza, professore? – Figliolo, se mi sentissi un tantino meglio, dovrei chiamare il medico, – disse il vecchio Spencer. Questo lo mise fuori combattimento. Cominciò a ridacchiare come un matto.
Ciò che crea disappunto in Holden nel commiato dal suo professore di storia non sono tanto le circostanze dell’incontro – il vecchio professore influenzato, in pigiama e vestaglia, chiuso nella sua stanza piena di medicine e dei relativi afrori – quanto piuttosto le modalità d’interlocuzione che il professore gli impone e che Holden registra all’insegna della impossibilità di comunicare. E ciò fin dall’inizio, quando il professore non lo invita semplicemente ad entrare, ma lo fa “gridando”: perché mai gridare quando l’interlocutore è a pochi passi di distanza e non è duro d’orecchi? E’ questo uno scarto, sia pur modesto, della “normalità” della comunicazione faccia a faccia che, come molti altri a seguire, dà “sui nervi” a Holden.
L’intera storia che Holden racconta, a partire da questo incontro, può essere letta come una rassegna tipologica di scarti da una normalità che Holden non vede praticata dai suoi interlocutori e che è all’origine dei suoi “nervi”, delle sue “rabbie”, del suo “perdere le staffe”, dei suoi “vomiti”: tutte forme emotive in cui si manifesta la sua identità di giovane alla ricerca, diremo con Barthes e Flahault (1980), del “dono della parola”.
Fermiamoci qui, ci sarebbe tanto da esplorare e da scrivere. La nostra gioventù, dall’universale Italia al particolare Agro, attraversa un momento difficilissimo, forse acuito dai troppi mesi di segregazione pandemica. Come aiutarla ? Chi deve e può aiutarla ? Cosa fanno scuola, famiglia, parrocchia e associazioni ?







