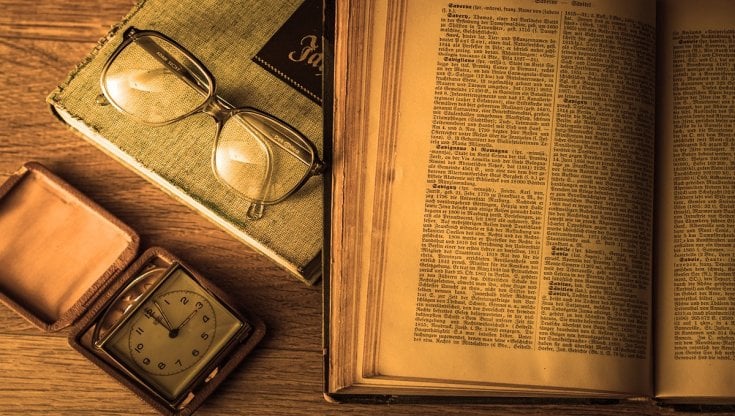
Paolo Giovio, di nobile discendenza, nacque a Como il 21 aprile del 1483 e morì a Firenze il 12 dicembre del 1552. Fu medico, umanista e uno degli storici più importanti del suo tempo. Durante il sacco di Roma, Paolo Giovio rimase sempre accanto al pontefice e, a ricompensa della sua fedeltà, Papa Clemente VII il 6 luglio del 1527 lo nominò vescovo della Diocesi di Nocera, dopo che, beninteso, come si faceva spesso a quei tempi persino per i Papi, il cortigiano comasco fu consacrato ormai in età matura con gli ordini maggiori. Non si conosce quasi nulla circa l’amministrazione della sua sede vescovile che, come il vescovo Giacobazzi prima di lui, egli governò tramite vicari. In realtà Paolo Giovio non si stabilì mai a Nocera non solo perché non c’era l’obbligo di residenza dei vescovi nelle sedi diocesane, ma soprattutto perché amava la vita mondana. Infatti, l’onore di una Diocesi povera per il suo tenore di vita e fuori mano, gli sembrò sempre poca cosa rispetto alle capacità e alle aspettative che aveva creato. Chi era, dunque, Paolo Giovio?
Paolo Giovio incarna nel bene e nel male un certo modello di letterato, tipico della sua età, dedito a studi severi e a compilazioni erudite e contemporaneamente appagato dai riti di una spesso frivola e ambiziosa mondanità, non esente da servilismo e cortigianeria nei confronti dei potenti. Come uomo, infatti, “amava il quieto vivere, lo stato di pace, l’arrendevolezza ai più forti”, attratto da piaceri molto terreni, soprattutto quelli della tavola, per sua stessa ammissione: “Un prelato da poltrona”, uno che “amava i cuscini di velluto, le donne giovani e le vecchie bottiglie” più delle responsabilità morali e spirituali del suo ministero, come sottolinea un suo studioso, Ettore Rota. Secondo la definizione molto lapidaria di Vittorio Cian, queste sue passioni Paolo Giovio le lascia trasparire talvolta esplicitamente, altre volte con allusivi ammiccamenti un po’ in tutte le sue opere, soprattutto dalle lettere, intrecciando all’elogio di vini, di pesci, di bellezze monumentali e di amenità paesaggistiche l’esaltazione di “leggiadre donne”. A riprova della sensibilità per la bellezza di queste ultime, basterebbe rileggere la lettera al cardinale Pietro Bembo del 15 luglio del 1530, in cui dichiara di amare di un amore “celeste, santo e platonicissimo” Vittoria Colonna, “armonia delle cose più belle”; non meno esplicito il passo dell’inedito Dialogus de viris et foeminis aetate nostra florentibus (Dialogo intorno agli uomini e alle donne del nostro tempo), là dove della stessa si sofferma ad ammirare i “seni tondeggianti… come balzano mollemente e leggiadramente, al ritmo del respiro, su dalle piccole fasce, che severamente li frenano, e, a guisa di colombe giacenti, si gonfiano a dolci intervalli”. Il suo amore poi per la buona tavola è testimoniato, se non da altro, dall’operetta De romanis piscibus libellus (Sui pesci romani), in cui l’autore si abbandona a una compiaciuta, dottissima rassegna di prelibatezze gastronomiche, frutto, più ancora che della sua competenza di medico, della sua diretta esperienza di buongustaio. A confortare quest’ultima impressione, si potrebbero citare i versi burleschi del Carmen facetum de fasiano (Carme faceto intorno al fagiano), letto in un codice della Biblioteca Vaticana e pubblicato da Vittorio Cian nel 1891, in cui Paolo Giovio si abbandona con evidente soddisfazione alla rappresentazione delle abitudini goderecce ed epicuree di prelati e parassiti della corte di papa Clemente VII, colta in uno dei suoi abituali e proverbiali momenti di ritrovo.
Paolo Giovio, quindi, fu un salottiero elegante che amava la buona tavola, le belle donne, la vita tranquilla, e quando fu nominato vescovo della Diocesi di Nocera incarnò il tipico prelato rinascimentale, le cui responsabilità morali, pastorali e religiose erano messe all’ultimo posto delle sue attività.








