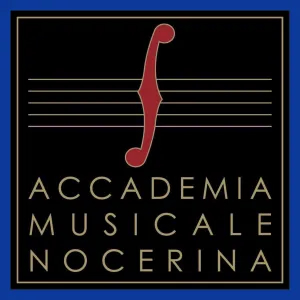La Duchessa Giovanna Castriota Scanderbeg moglie del Duca di Nocera de’ Pagani Alfonso Carafa, oltre ai Frati Minori Cappuccini fu molto vicina anche all’Ordine dei Gesuiti. Infatti, un’altra istituzione che svolse un ruolo importante tra il XVI e il XVIII secolo, furono i collegi della Compagnia di Gesù, e in particolare i cosiddetti seminaria nobiluim, cioè collegi di educazione riservati ai nobili. Essi operarono egregiamente nella trasmissione dei valori caratterizzanti l’ideologia del gentiluomo: il disprezzo delle arti meccaniche, il culto dell’onore, la passione per la genealogia e l’araldica.
Inoltre, cooperarono ad addestrare i nobili, a prescindere dalla loro futura professione nel mondo, alle arti mondane del ballo, della musica, della cavallerizza, della scherma, della rappresentazione teatrale. Tuttavia, tra le personalità degli Ordini religiosi che frequentavano Nocera de’ Pagani per merito della Duchessa Giovanna Castriota Scanderbeg, spicca senza dubbio il teatino Sant’Andrea Avellino, una personalità molto nota in quel periodo e oggi quasi sconosciuta, che soggiornò molte volte a palazzo ducale. Vediamo, dunque, chi era questo servo di Dio e che rapporti ebbe con la Duchessa Giovanna Castriota Scanderbeg. Sant’Andrea Avellino nacque a Castronuovo (Potenza) nel 1521, da Giovanni e da Margherita Apelli, signori fra i più facoltosi del paese. Il suo nome di battesimo era Lancellotto e nel 1545 fu ordinato sacerdote. Nel 1547 Andrea si iscrisse alla facoltà di diritto dell’università di Napoli e alloggiò in via San Pietro a Maiella, nei pressi di San Paolo Maggiore, dove, nell’agosto di quello stesso anno, era morto Gaetano Thiene, fondatore dei teatini, con i quali iniziò ben presto cordiali rapporti. Laureatosi in utroque iure (la locuzione latina in utroque iure, tradotta letteralmente, significa nell’uno e nell’altro diritto ed era utilizzata nelle prime università europee per indicare i dottori laureati in diritto civile e in diritto canonico), fu avvocato del foro ecclesiastico, ufficio che però egli abbandonò dopo averne sperimentati i pericoli in seguito a una menzogna sfuggitagli nel calore di una arringa e che gli provocò un profondo sconforto. Nel 1551 da Monsignore Scipione Rebiba, gli fu affidata la cura e la riforma del tristemente monastero delle monache di Sant’Arcangelo a Baiano in Napoli, missione che egli intraprese con grande zelo. Perseguitato da un giovane che aveva con una monaca del monastero illecite relazioni e dopo essere sfuggito a un duplice attentato, nel 1556, fu ferito gravemente da un sicario assoldato da chi non tollerava la sua azione riformatrice. Accolto dai teatini di San Paolo Maggiore e guarito, chiese e ottenne, il 30 novembre dello stesso anno, l’abito di quella congregazione prendendo il nome di Andrea. Tra il 3 aprile e l’8 maggio del 1559 fece un pio pellegrinaggio a Roma, dove fu ricevuto da Paolo IV, il quale era stato con Gaetano Thiene fondatore dei teatini. Nel 1560 Sant’Andrea Avellino fu nominato maestro dei novizi della casa di San Paolo Maggiore in Napoli, carica che tenne per dieci anni. Dal 1571 al 1581 svolse in Lombardia il suo apostolato tutto improntato ai criteri e alle esigenze della riforma cattolica. Nel maggio del 1582, ritornò a Napoli, dove proseguì la sua attività religiosa con la parola, gli scritti e la direzione spirituale delle anime, per cui si sentiva. Dotato di grazie straordinarie di orazioni, del dono dei miracoli e della profezia, non meno che di una vasta dottrina teologica, egli rafforzò la pietà nel popolo e ne difese la fede. Il 10 novembre del 1608, mentre, nella chiesa di San Paolo Maggiore, iniziava la celebrazione della messa, fu improvvisamente colpito d’apoplessia. Morì nello stesso giorno, nella sua stanza, oggi trasformata in cappella. Beatificato da Urbano VIII il 4 ottobre del 1624, fu canonizzato da Clemente XI il 22 maggio del 1712. La sua festa si celebra il 10 novembre.
Il suo corpo, che riesumato fu riconosciuto intatto, si venera in San Paolo Maggiore. È invocato celeste protettore contro la morte improvvisa. Dalle opere come dalla vita di Sant’Andrea Avellino se ne può individuare la spiritualità. Egli si muove nell’alveo di quell’ascetismo solido, equilibrato, schiettamente evangelico, proprio anche del suo Ordine. Secondo Sant’Andrea Avellino la vera vita spirituale si fonda attorno a due principi: nel disprezzo di se stessi e di tutte le vanità del mondo; e amare Dio senza limiti mirando soprattutto all’imitazione di Cristo. Nella storia della spiritualità del Cinquecento, Sant’Andrea Avellino senza dubbio merita un posto di prim’ordine. Egli, infatti, fino agli ultimi giorni della sua vita, fu il padre spirituale di molte nobildonne del Regno di Napoli tra cui Giovanna Castriota Scanderbeg, come si evince dallo stralcio di questa lettera scritta dal Santo il 16 settembre del 1567 e indirizzata proprio alla Duchessa di Nocera de’ Pagani: “(…) Imperoché non si ritrova maggior’ amore, ne più honesto di quello, che i padri portano à i loro figliuoli, à quali desiderano ogni honore, ogni gloria, & ogni bene, desiderando ponere per quelli mille volte la loro vita: Così desidero far’ io per la sua salute. Per tanto, poich’ ella mi vuole per padre, io ancora con ogni umiltà, riverentia l’accetto per figliuola”. Prima di continuare, sarà utile evidenziare che Sant’Andrea Avellino scrisse, in diverse occasioni, moltissime lettere sia ai popolani sia ai nobili. Esse contengono ammonizioni celesti per ritornare a Dio, e consigli ed esortazioni, per facilitare chi veramente vuole servire il Signore Gesù Crocifisso. Queste lettere furono raccolte e pubblicate in un’unica opera col titolo: “Lettere scritte dal glorioso S. Andrea Avellino a diversi suoi divoti, date alla luce da’ Chierici Regolari di S. Paolo Maggiore di Napoli. Nella stamperia di Novello de Bonis, Napoli 1731”. Il principale promotore di quest’opera fu P. Giuseppe Maria Brembatì, Preposito Generale dei Teatini dal 1731 al 1734. Il Preposito e i Chierici Regolari della Casa di San Paolo Maggiore in Napoli, la dedicarono al Cardinale teatino Francesco Pignatelli, decano del Sacro Collegio e Arcivescovo di Napoli. L’opera è formata da due volumi che contengono più di mille lettere scritte da Sant’Andrea Avellino ai suoi devoti e ad altre anime pie. Le lettere di Sant’Andrea Avellino sono delle vere e proprie lezioni di teologia e, in alcuni tratti, mostrano una profonda competenza nell’esegesi biblica. A Nocera de’ Pagani, Sant’Andrea Avellino soggiornò molte volte a palazzo ducale su richiesta di Giovanna Castriota Scanderbeg, e in quelle occasioni fu sempre circondato da molte nobildonne che non mancava mai di ammonire. Infatti, questa lettera inviata a Giovanna Castriota Scanderbeg il 20 settembre del 1588, ne è l’esempio più chiaro: “Son ritornato da Nocera consolato, havendo concepito una grandissima speranza della salute di V.E. e di queste altre Signore; Poiché ciascuna di loro si tiene inferiore all’altre nella vita spirituale, ogni una considerando i suoi proprii difetti, e le virtù dell’altre, serrando gli occhi all’altrui difetti, quali non vede; Imperoché la persona, ch’attende à considerare i suoi proprii difetti (stando totalmente occupata in questa considerazione, per espugnarli) non hà tempo di vedere i difetti d’altri; ma solamente considera le virtù del prossimo, per imitarli, come faceva Santo Antonio”.
Per venticinque anni, dal 1567 al 1592, Sant’Andrea Avellino fu il padre spirituale di Giovanna Castriota Scanderbeg alla quale indirizzò moltissime lettere. Dall’analisi di alcune di queste lettere, si apprende che all’inizio del 1592 Giovanna Castriota Scanderbeg, da molto tempo gravemente ammalata, ormai desiderava morire tra le braccia del Santo. Infatti, in questa lettera commovente scritta il 30 gennaio del 1592 alla Duchessa di Nocera, Sant’Andrea Avellino dice: “Hò ricevuta la sua gratissima delli 16. del passato, & hò sentito contento, che le mie lettere l’apportano consolatione, e refrigerio in questo suo gran male, che tanto l’hà sbattuta (…) io resto à pieno sodisfatto delle mie fatiche, per grandi che fussero co’ l solo intendere, che V.E. ne riceve refrigerio, e consolazione in questa sua lunga, e grave infermità, poiché ‘l fine delle mie fatiche, altro non è, se non giovare, e consolare la travagliata, & afflitta anima sua (…). Io insieme con lei desidero che presto venga in queste parti, non per vederla morire nelle mie braccia, com’ella scriva, e desidera, ma acciò ricuperi alquanto di sanità per esercitarsi nelle bone opere, colla gratia del Signore, acciò cresca di merito, e di gloria”. Questa fu l’ultima lettera che Sant’Andrea Avellino scrisse a Giovanna Castriota Scanderbeg poiché dopo qualche tempo la Duchessa morì. È lo stesso Santo che ci informa della morte avvenuta della Duchessa in due lettere. Nella prima del 18 agosto del 1592 scritta a Dorotea Spinella Contessa d’Altavilla comunica: “(…) e per questa grandissima compassione, ch’io l’hò, le scrivo così allo spesso, com’ella desidera, il che non hò fatto con altre, né meno colla Sig. Duchessa di Nocera, quale m’era tanto cara, per lo gran profitto, che faceva nella vita spirituale, vincendo le sue naturali passioni, sì per glorificare Iddio, sì anco per dare contento à me che desiderava la sua salute”. Nella seconda del 9 novembre del 1592 scritta a Isabella Gonzaga Principessa di Stigliano ripete che: “Quanto allo scriverle spesso, V.E. stia sicura, che se le mie lettere l’apportano quello giovamento, e consolatione, ch’ella mi scrive, non mancherò di rispondere à tutte le sue lettere, com’hò fatto alla Serenissima Signora Principessa di Parma, & all’Eccellentissima Signora Duchessa di Nocera, quali sono passate à miglior vita”. Alla luce di queste preziose informazioni possiamo terminare dicendo che molto probabilmente la Duchessa Giovanna Castriota Scanderbeg morì tra febbraio e giugno del 1592.