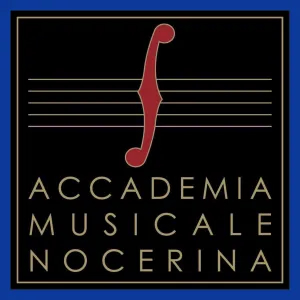“Parthenope”di Paolo Sorrentino è molto più di un semplice film; è un viaggio antropologico attraverso l’anima di Napoli. Incarnata nella figura Parthenope,la città emerge come una madre mancata, insicura, che insegue la maternità senza mai afferrarla pienamente. È una Napoli innamorata dei suoi figli più pezzentelli, zandraglioni, eccentrici ed eccessivi, una madre che accoglie e respinge simultaneamente, avvolta in un caos vitale e contraddittorio.
Sorrentino riesce a catturare l’essenza di Napoli, mostrando una città che brilla di luce propria, ma al contempo è inseguita dalle ombre delle sue stesse contraddizioni. La rappresentazione di Napoli in “Parthenope” è completa e complessa, spaziando da San Gennaro alla sessualità sganciata, ritualistica e patetica che si ripete alla ricerca di un piacere effimero. La città è un teatro di manierismo, dove ogni personaggio, sembra incarnare un rito pagano, una celebrazione della vita in tutte le sue forme. Napoli che non giudica mai e si chiede costantemente a cosa stiamo pensando.
Sorrentino si autocelebra e si autocita, creando un’opera che è al tempo stesso un omaggio e una critica alla sua stessa visione artistica. Gli amori giovanili, che sembrano non servire a nulla, sono rappresentati in modo che rievocano Fellini, con un autoerotismo concettuale che permea l’intera opera. La visione di Sorrentino sembra senza centro, e sconfina senza colpire un punctum, creando un affresco di Napoli che è al tempo stesso caotico e affascinante.
La scena del figlio disabile, in particolare, richiama le opere di Fellini per la sua capacità di rappresentare la fragilità umana e la lotta per trovare un senso di appartenenza. Come nei film di Fellini, anche in “Parthenope” i personaggi marginalizzati e vulnerabili sono ritratti con una dignità e una bellezza nascosta che li rende indimenticabili.
Non si può dire di amare o odiare “Parthenope”; è un film che va sezionato come farebbe un antropologo etnologico, che guarda e osserva senza giudicare. Silvio Orlando, con la sua interpretazione, diventa quasi un alter ego dello spettatore, invitandoci a entrare in questo viaggio senza pregiudizi.
Però diciamolo, è un film un po’ maschilista!
Parthenope non ha amiche ed anche sua madre non l’accoglie.
Parthenope è una ragazza sola continuamente aggredita da sguardi libidinosi di una variegata moltitudine di uomini spesso deboli e spregevoli.
Ma cio nonostante, Sorrentino ci mette tutto ma proprio tutto di se.
C’è il suo amore a tratti bipolare, incestoso,esteta e manierista per la sua la nostra Napoli.
Benché vi sia una narazzione maschilista, questa allo stesso tempo ha uno sguardo tenero sulle donne più mature quelle che restano attaccate a brandelli di vetusta beltà, l’ironia tipica di Sorrentino stavolta rasenta i limiti della blasfemia che prende di mira la religiosità che cammina a braccetto col peccato.
In conclusione, “Parthenope” è un’opera che cattura l’essenza di Napoli in tutta la sua complessità e vitalità. Sorrentino ci offre una visione antropologica e felliniana della città, celebrando i suoi figli più eccentrici e la sua cultura unica. Un film che lascia un’impronta indelebile e che invita a riflettere sulla natura umana e sulla ricerca di un senso di appartenenza. Chi guarda “Parthenope” deve farlo con l’occhio attento e imparziale di un antropologo, pronto a cogliere ogni sfumatura senza preconcetti, in un viaggio che va oltre il semplice intrattenimento cinematografico.