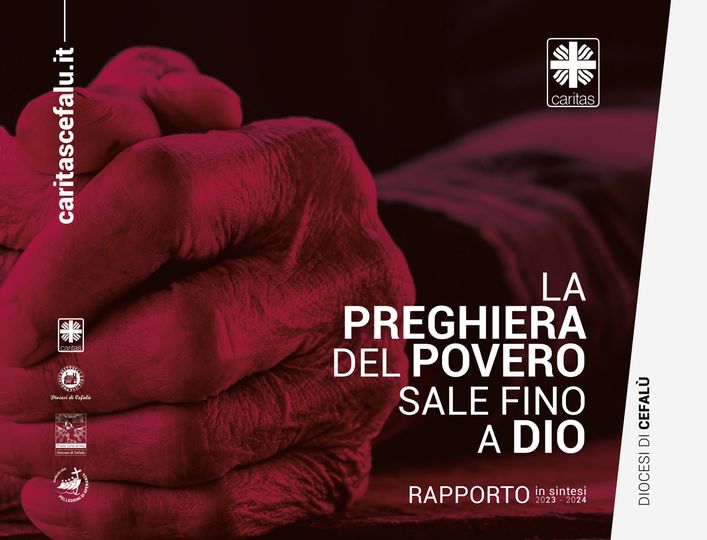
Lo stretto binomio tra povertà economica e povertà educativa
È ormai noto come in Italia l’incidenza della povertà sia strettamente correlata al titolo di studio, tende cioè a essere più marcata nella popolazione con bassi livelli di scolarizzazione. I recenti dati Istat, rilasciati lo scorso 17 ottobre, evidenziano come nelle famiglie prive di un diploma superiore la povertà assoluta sia tre volte più alta rispetto a quelle dove la persona di riferimento
è diplomata (12,3% vs 4,6%). Se si guarda ai dati Caritas il forte binomio tra povertà economico-materiale e di istruzione appare ancora più evidente visto che, tra le persone che chiedono aiuto, oltre i due terzi (il 67,3%) può contare al massimo su un titolo di licenza media inferiore (tra loro si contano anche tanti con la sola licenza elementare o senza alcun titolo di studio). L’istruzione può dirsi quindi senza dubbio un fattore di protezione e, al contempo, di mobilità sociale. In tal senso, l’Unione Europea, nel definire un set di indicatori di disagio sociale comune, ha individuato nel possesso del diploma di scuola superiore la condizione minima per il superamento del rischio di esclusione sociale. Tuttavia, se è vero che il titolo di studio è in grado di preservare dalle condizioni di povertà, è altrettanto vero che a sua volta la stessa istruzione può essere condizionata dalla situazione di partenza, quindi
dalla famiglia di origine. L’Italia a riguardo si caratterizza come uno dei Paesi a più bassa mobilità educativa in Europa. Se ci si sofferma ad esempio sugli abbandoni scolastici, i dati Istat confermano che oggi quasi un quarto (23,9%) dei giovani (18-24) con genitori privi di un diploma ha abbandonato gli studi prematuramente; la quota scende al 5,0%, se almeno un genitore ha un titolo secondario superiore e all’1,6% se è laureato24. Anche tra gli assistiti Caritas si ravvisano le stesse dinamiche: l’incidenza dei possessori di licenza media risulta più marcata proprio in corrispondenza di genitori con titolo elementare o con la stessa licenza media, e addirittura tra i nati da genitori senza alcun titolodi studio quasi un beneficiario su tre si è fermato alla sola licenza elementare. L’attenzione delle Caritas diocesane e parrocchiali sul tema della povertà educativa è molto alta, e tante possono dirsi le progettualità pensate al fine di
spezzare la catena della povertà intergenerazionale. Tra queste si possono citare:
l’erogazione di budget educativi e culturali; l’affido culturale; le attività di
doposcuola e aiuto compiti; gli accordi/protocolli di intesa tra Caritas e scuole; gli assegni di sostegno allo studio a studenti meritevoli provenienti da famiglie in difficoltà (in sinergia con le istituzioni scolastiche); i regalo/libri sospesi per bambini e ragazzi; i patti educativi con le famiglie (famiglie aiutate sul fronte materiale a cui si chiede loro di garantire la frequenza scolastica dei propri figli);
l’attivazione di comunità educanti e di patti educativi tra soggetti delle comunità; i percorsi di alternanza scuola-lavoro e di volontariato extrascolastico.
Al tema della povertà educativa è stato anche dedicato il rapporto 2024 della Caritas diocesana di Aversa, dal titolo “FormAzioni”; all’interno del volume vengono presentate alcune buone pratiche per il contrasto alla dispersione scolastica sottolineando l’importanza delle sinergie dei tanti soggetti che collaborano con le scuole al fine di costruire “reti di scopo”; si legge nel report:
“parrocchie, operatori sociali e associazioni devono organizzarsi «in-formazioni» con le scuole, al fine di fronteggiare quella che ormai può dirsi una vera e propria emergenza sociale”.
In alcuni casi si parla di veri e propri patti educativi locali, come quello della Caritas diocesana di Messina, in linea con la proposta che fece Papa Francesco nel 2019 relativa all’istituzione di patti educativi globali per «ravvivare l’impegno per e con le nuove generazioni, rinnovando la passione per un’educazione più aperta e inclusiva, capace di ascolto paziente, dialogo costruttivo e mutua comprensione». Quando il lavoro non basta
Oltre ai bassi livelli di istruzione un fattore che accomuna la gran parte delle persone che si rivolgono alla rete Caritas è la fragilità occupazionale, una vulnerabilità che si esprime per lo più in condizioni di disoccupazione (48,1%) e di
“lavoro povero” (il 23% dichiara infatti di avere una occupazione). Non è solo dunque la mancanza di un impiego che spinge a chiedere aiuto: di fatto quasi un beneficiario su quattro rientra nella categoria del working poor, con punte che arrivano al 26,1% in Toscana e al 28,4% in Piemonte. Lavorare spesso non basta; quasi la metà di chi possiede un’occupazione dichiara di non avere un reddito adeguato e di fatto anche chi non lo ammette dimostra di non farcela.
Le persone con un impiego che hanno bisogno di aiuto sono per lo più di cittadinanza straniera (65%); uomini (51,6%) e donne (48,4%); di età compresa tra i 35 e i 54 anni (60,2%); genitori di figli minori (70,3%); domiciliati presso case in affitto (76,6%); monogenitori nel 51,7% dei casi; con storie assistenziali intermittenti.
Se si guarda al tipo di professioni svolte, tra gli uomini si nota una molteplicità di mansioni che ruotano tra i settori dell’edilizia, della ristorazione, della vendita ambulante, oppure di una categoria che definiremmo “i tuttofare”: traslocatori, giardinieri, corrieri, ecc.; le donne invece lavorano per lo più nel settore delle pulizie domestiche, nell’area della cura dei bambini e degli anziani.
Spesso si tratta di persone con carriere lavorative poco lineari, molto segmentate, piuttosto articolate dal punto di vista delle mansioni svolte e rispetto alle condizioni contrattuali. I vari ambiti di impiego hanno spesso in comune un basso livello di intensità lavorativa e la precarietà. La più alta incidenza di occupati tra gli assistiti si registra nelle regioni del Nord-Ovest (28,8%) e del Nord-Est (26,1%). E di fatto, proprio recentemente, alcune Caritas della Lombardia si sono soffermate su questo aspetto, sottolineando
l’incremento della componente occupata tra gli assistiti come, ad
esempio, la diocesi di Brescia. Interessante a riguardo anche l’analisi di lungo periodo condotta da Caritas Ambrosiana e inserita all’interno del rapporto pubblicato lo scorso ottobre che dà il polso del cambiamento sociale in atto: dal 2016 al 2023 il peso dei disoccupati tra gli assistiti è passato dal 62,5% al 49,1% (è diminuito di 13,4 punti percentuali) mentre di contro la percentuale di occupati nello stesso periodo è aumentata di 9,4 punti (passando dal 14,5% al 23,9%)32. Il tutto appare perfettamente in linea con i dati della statistica pubblica in riferimento alle difficoltà delle aree del Nord. Anche l’ultimo report della Caritas diocesana di Rimini si sofferma su questo tema evidenziando: “un solo stipendio non basta più in una casa; a volte non ne bastano neppure due, perché non solo gli affitti sono troppo alti (nonostante risultino inferiori rispetto al 2022), ma ad aumentare, nel 2023, ci sono state le spese alimentari, i trasporti, i beni e servizi alla persona, lo sport e tanto altro”
– Continua







