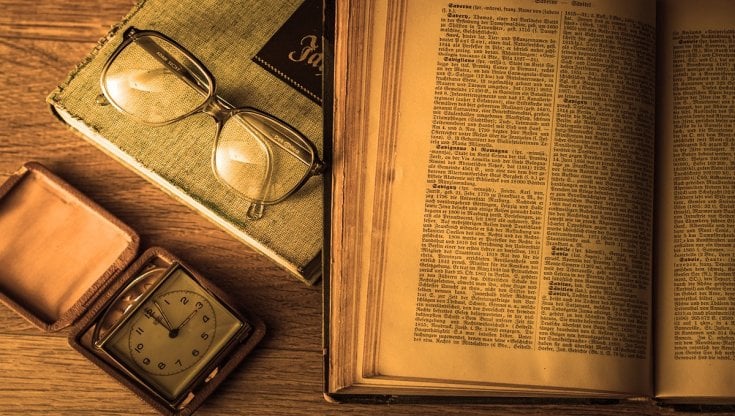
I Romani imponevano alle loro donne il dovere di non parlare, di essere discrete e obbedienti e come afferma Eva Cantarella “di stare al loro posto, insomma, secondo le regole di una società che, in buona sostanza, le vuole ascoltatrici, e non interlocutrici degli uomini”. Non a caso, uno degli archetipi femminili romani è Tacita Muta.
La storia di Tacita Muta, una divinità romana dei morti che fu punita per non aver tenuto a freno la lingua, è tramandata da Ovidio nei Fasti (II, vv. 585-613). Costei, in origine, era una ninfa, conosciuta come Lara, un nome che richiamava chiaramente il verbo parlare. Un giorno ebbe la malaugurata idea di confessare alla sorella Giuturna l’amore che Giove nutriva per lei, vanificando i tentativi del dio di sedurla, così Giove decise di punirla strappandole la lingua e confinandola nel regno dei morti. Il mito di Tacita Muta ci tramanda la storia di una donna incauta, leggera e irriflessiva, che aveva fatto cattivo uso della parola, quella stessa parola di cui i Romani andavano particolarmente fieri, se ben utilizzata. In questo contesto culturale appare quasi inconciliabile l’essere donna con la qualità di testimone in giudizio.
Tuttavia, vi furono dei processi nei quali furono chiamate a testimoniare anche le donne. Tacito, infatti, riporta un caso in cui si dimostrò il coraggio di una matrona, che però non servì a salvare la vita al condannato: l’episodio della matrona Vitellia. Tacito, infatti, nei suoi Annali (III, 49) ci racconta che: “Fine anni Clutorium Priscum equitem Romanum, post celebre carmen quo Germanici suprema defleverat, pecunia donatum a Caesare, corripuit delator, obiectans aegro Druso composuisse quod, si extinctus foret, maiore praemio vulgaretur. Id Clutorius in domo P. Petronii socru eius Vitellia coram multisque inlustribus feminis per vaniloquentiam legerat. Ut delator extitit, ceteris ad dicendum testimonium exterritis, sola Vitellia nihil se audivisse adseveravit. Sed arguentibus ad perniciem plus fidei fuit, sententiaque Haterii Agrippae consulis designati indictum reo ultimum supplicium”. Nel 21 d.C. il cavaliere e poeta Clutorio Prisco, il quale aveva ricevuto in dono dall’imperatore Tiberio una consistente cifra di denaro per aver composto un epitaffio in onore di Germanico, lesse in casa di P. Petronio, alla presenza di Vitellia suocera del padrone di casa e di altre matrone, un suo componimento scritto per l’eventualità che Druso minore, figlio dell’imperatore Tiberio, gravemente malato, fosse morto. Clutorio Prisco ebbe anche l’impudenza di asserire che se Druso minore fosse morto avrebbe avuto un compenso sicuramente superiore rispetto al precedente.
Naturalmente, i delatori non si fecero sfuggire un’occasione così ghiotta e quindi iniziò il processo nei confronti del cavaliere con l’accusa di lesa maestà. Tra i vari testimoni, furono chiamate anche le donne che avevano ascoltato la declamazione le quali confermarono l’accusa, tranne Vitellia, che coraggiosamente sostenne di non aver sentito niente: “sola Vitellia nihil se audivisse adseveravit”. Nonostante il tentativo di Vitellia di proteggerlo Clutorio Prisco non ebbe salva la vita. Prevalsero, infatti, le testimonianze di quanti volevano la sua rovina e il Console designato, Aterio Agrippa, chiese e ottenne la pena di morte. Chi era dunque questa coraggiosa matrona?
Vitellia apparteneva alla Gens Vitellia, una famiglia di Nuceria che scalò i vertici del potere di Roma. Vitellia, infatti, nacque a Nuceria ed era la sorella di Publio Vitellio procuratore di Augusto e zia di Publio Vitellio il Giovane, un fedelissimo di Germanico, e di Lucio Vitellio padre di Aulo Vitellio il futuro imperatore romano nel 69 d.C. Come ci conferma Mario Pani, Vitellia sposò un A. Plauzio che fu Console nell’1 a.C. e dalla loro unione nacque A. Plauzio che fu Console nel 29 d.C. e poi potentissimo legato dell’imperatore Claudio in Bretagna. All’epoca dei fatti, Vitellia era un’anziana matrona animatrice di quei salotti letterari che furono tanto cari alle signore della Roma bene. Non è da escludere, inoltre, dato il rango sociale e l’età, che lei stessa fosse stata buona amica non solo di Giulia maggiore madre di Agrippina maggiore, ma con la stessa Agrippina maggiore, la moglie del defunto Germanico sempre più sfrenata a proclamare che la morte del consorte non era stata casuale, e che l’imperatore Tiberio ne era stato il responsabile. Infatti, la comune avversione nei confronti dell’imperatore Tiberio, testimoniata dal rifiuto di Vitellia a collaborare nell’accusa mentre, “indotte dalla paura”, le altre matrone furono costrette a farlo: “ad dicendum testimonium exterritis”, tutto lascia intendere che la matrona Vitellia e Agrippina maggiore andavano molto d’accordo e molto probabilmente avevano anche la stessa visione politica.
Dopo questo episodio le fonti su Vitellia tacciono, pertanto non è possibile risalire né alle cause né all’anno della sua morte.








