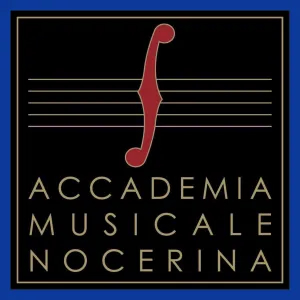Il componimento poetico La salubrità dell’aria fu redatto da Giuseppe Parini nel 1759, e poi inserito nella prima edizione delle Odi nel 1791, in occasione di una riunione accademica dei Trasformati, il gruppo di intellettuali lombardi (tra cui Cesare Beccaria, Giuseppe Baretti e Pietro Verri) cui Giuseppe Parini aderisce nel 1753.
L’Ode su La salubrità dell’aria è di impostazione argomentativa puramente civile. Giuseppe Parini elabora qui le tematiche illuministiche diffuse nel gruppo dei Trasformati e per queste sceglie uno stile alto e letterario, che si adatta al contenuto realistico dell’Ode e al messaggio etico del poeta. Il tema proposto è quello dell’aria, che il poeta sviluppa all’insegna di uno spiccato impegno civile e morale, lanciando un appello “ecologico” agli abitanti di Milano per sostenere la necessità del miglioramento delle condizioni ambientali della città. Giuseppe Parini tratta dunque un argomento di stringente attualità mediante uno stile intriso di realismo e, al tempo stesso, di suggestioni classiche.
Il componimento è formato da centotrentadue versi, divisi in ventidue strofe di sei versi ciascuna, detti anche sestine. Il metro usato è il settenario piano dove le rime sono alternate nei primi quattro versi e baciate negli ultimi due. Lo schema delle rime è quindi ABABCC.
La tematica principale è la differenza di condizioni igienico-sanitarie tra Bosisio e la Brianza rispetto a Milano. Infatti, il componimento poetico si apre con la descrizione dei luoghi d’origine dell’autore, cioè Bosisio e dintorni. Lì l’aria è pura e giova ai polmoni
inquinati e indeboliti dall’aria di città, inoltre non arrivano né lo Scirocco né la Tramontana, perché le montagne che circondando il paese non lo permettono. Non ci sono paludi di acqua stagnante, dunque neppure insetti portatori di malattie. L’unica acqua che c’è all’infuori dei laghi è quella della rugiada che è asciugata la mattina con il sole. A questo punto comincia la condanna dell’autore verso colui che ha provocato l’ inquinamento di Milano, senza tener conto della comunità. Secondo la legge del contrappasso, costui sarà punito nei fanghi del fiume Stige, con il viso sommerso dalla
melma e disperandosi per ciò che fece in passato per lucro. Giuseppe Parini definisce malati i coltivatori di riso nei dintorni di Milano, e si rivolge al cittadino chiedendogli di riflettere su questi problemi. Ora l’autore esprime il suo desiderio di passare le giornate dove il clima è piacevole e, dove, i contadini lavorano, robusti e sani. Descrive la gente di
campagna come gioiosa e felice della vita, che si accontenta di semplici cose. Anche Milano tuttavia un tempo era così: nessuno dei contadini, però, in preda all’egoismo, ha pensato di preservare questi doni. Oltre alle putride risaie, hanno deviato anche il corso dei torrenti per allagare i propri campi. Giuseppe Parini descrive anche le strade della
città di Milano: le persone gettano i rifiuti per strada; carogne di animali che portano malattie e cattivi odori. Anche se dopo il tramonto i netturbini puliscono, l’indomani tutto ritorna come prima perché i cittadini non hanno rispetto delle leggi e non si rendono conto del danno che recano alla collettività e a se stessi.
Infine l’autore si rivolge a se stesso domandandosi perché vada così lontano da quella campagna pulita e salutare e si rivolge alla fantasia, identificandola come utile alla denuncia dell’inquinamento. L’obiettivo del poeta è quindi quello di farsi voce critica contro la nobiltà e la classe dirigente, inadatta e incapace di provvedere al bene comune poiché e interessata solo ai propri profitti privati, derivanti ad esempio dalla coltivazione delle marcite o delle risaie nei pressi della città. La tematica dell’aria, attraverso lo strumento della poesia, diventa così una questione di responsabilità civile e sociale che coinvolge tutti.